I film della settimana: “This is my land… Hebron” e “Left by the ship”
Giona A. Nazzaro
THIS IS MY LAND… HEBRON di Giulia Amati, Stephen Natanson
LEFT BY THE SHIP di Emma Rossi-Landi, Alberto Vendemmiati
Se non si presta sufficiente attenzione c’è il rischio molto concreto che alcuni dei film italiani più interessanti degli ultimi mesi rischiano di scomparire dopo pochissimi giorni di programmazione.
Ci sono infatti delle ottime iniziative, ancora troppo ridotte di numero, ma esistono, che s’impegnano per far circolare un cinema italiano meritevole di tutta l’attenzione possibile.
È il caso, per esempio di This is my land… Hebron diretto da Giulia Amati e Stephen Natanson e Left by the ship firmato da Emma Rossi-Landi e Alberto Vendemmiati.
Presentati entrambi in competizione nel corso dell’ultima edizione del Festival dei Popoli, i due film hanno conquistato ex aequo il premio della giuria di selezione Cinema.doc Firenze presieduta Riccardo Biadene e Christian Carmosino. In questo modo i film sono stati proiettati per tre giorni in tre cinema diversi di Roma richiamando un pubblico attento e partecipe che dopo la proiezione è restato in sala per discutere con gli autori delle problematiche affrontate dai film.
Se il nostro cinema cosiddetto maggiore sembra essere pigramente richiuso sui propri provincialissimi confini, esiste pur sempre un altro cinema che si sente parte integrante del mondo e delle sue problematiche. Un cinema che si muove al di là dei confini nazionali rischiando in proprio e indagando con gli strumenti del linguaggio e della forma filmica. Sia "This is my land… Hebron" che "Left by the ship" rilanciano un’idea di cinema civile lontana dalle partigianerie di turno privilegiando un approccio politico a tutto tondo.
 Left by the ship, realizzato nell’arco di due anni nelle Filippine, segue la storia di Robert, Jr, Charlene e Margarita, quattro amerasiatici, ossia figli di militari statunitensi di stanza nella base nato di Subic Bay, la più grande al di fuori degli stati uniti, situata a nord di Manila. Pensata, tra le altre cose, come “centro di ricreazione” per i marine, la base è diventata progressivamente il teatro di una tragedia silenziosa dimenticata da tutti tranne che dai diretti interessati. Infatti il villaggio di Olongapo, che sino all’arrivo degli americani era un piccolo villaggio di pescatori, è andata crescendo nel tempo adattandosi alle necessità della base sviluppando uno dei quartieri a luce rossa più grandi dell’Asia. Data la struttura della base, molti militari si ritrovavano a frequentare la medesima donna in un arco di tempo più o meno lungo dando vita così a un simulacro di famiglia nel quale inevitabilmente nascevano dei bambini. In questo modo, le ragazze che avevano lasciato le campagne inseguendo il miraggio di una vita migliore, finivano per fare da mogli in affitto ai soldati statunitensi. Così, stando alle statistiche, tra gli anni cinquanta e il 1992, anno in cui dopo la caduta di Marcos il senato filippino ha votato contro il rinnovo della permanenza delle basi statunitensi, sono nati più di 50000 bambini definiti come amerasiatici (la definizione è di Pearl S. Buck). Nel 1982, il Senato degli Stati Uniti approva la legge 97-359 che concede il diritto di cittadinanza statunitense ai figli di soldati americani nati in Corea, Vietnam, Tailandia e Laos ma non ai giapponesi e ai filippini. I soldati interessati ai propri figli filippini dovevano fare richiesta di cittadinanza entro il compimento del diciottesimo anno di età. Così, quando nel 1992 Subic Bay viene lasciata dai militari americani e trasformata in un porto franco, restano letteralmente abbandonati a se stessi decine di migliaia di bambini privi di qualsiasi ipotesi di futuro.
Left by the ship, realizzato nell’arco di due anni nelle Filippine, segue la storia di Robert, Jr, Charlene e Margarita, quattro amerasiatici, ossia figli di militari statunitensi di stanza nella base nato di Subic Bay, la più grande al di fuori degli stati uniti, situata a nord di Manila. Pensata, tra le altre cose, come “centro di ricreazione” per i marine, la base è diventata progressivamente il teatro di una tragedia silenziosa dimenticata da tutti tranne che dai diretti interessati. Infatti il villaggio di Olongapo, che sino all’arrivo degli americani era un piccolo villaggio di pescatori, è andata crescendo nel tempo adattandosi alle necessità della base sviluppando uno dei quartieri a luce rossa più grandi dell’Asia. Data la struttura della base, molti militari si ritrovavano a frequentare la medesima donna in un arco di tempo più o meno lungo dando vita così a un simulacro di famiglia nel quale inevitabilmente nascevano dei bambini. In questo modo, le ragazze che avevano lasciato le campagne inseguendo il miraggio di una vita migliore, finivano per fare da mogli in affitto ai soldati statunitensi. Così, stando alle statistiche, tra gli anni cinquanta e il 1992, anno in cui dopo la caduta di Marcos il senato filippino ha votato contro il rinnovo della permanenza delle basi statunitensi, sono nati più di 50000 bambini definiti come amerasiatici (la definizione è di Pearl S. Buck). Nel 1982, il Senato degli Stati Uniti approva la legge 97-359 che concede il diritto di cittadinanza statunitense ai figli di soldati americani nati in Corea, Vietnam, Tailandia e Laos ma non ai giapponesi e ai filippini. I soldati interessati ai propri figli filippini dovevano fare richiesta di cittadinanza entro il compimento del diciottesimo anno di età. Così, quando nel 1992 Subic Bay viene lasciata dai militari americani e trasformata in un porto franco, restano letteralmente abbandonati a se stessi decine di migliaia di bambini privi di qualsiasi ipotesi di futuro.
Segno tangibile di una politica di sopraffazione, questi bambini amerasiatici sono condannati a portare sul proprio corpo il segno di un padre assente che li ha rifiutati. Ed è andando a recuperare il diritto di parola di queste persone che left by the ship diventa un progetto cinematografico appassionante. Costruito con una fluidità estrema, prestando grandissima attenzione alla trasparenza del montaggio (aspetto cui gli autori hanno dedicato un anno della lavorazione), Rossi-Landi e Vendemmiati hanno realizzato un film politico lontanissimo dalle categorie dominanti in Italia. Calati nella realtà del luogo che hanno deciso di filmare, i due autori si sono fatti attraversare dalle voci e dalle storie dei protagonisti, aprendo il loro film come in un estremo atto di solidarietà e riuscendo al tempo stesso a offrirci il loro inconfondibile punto di vista su una vicenda atroce e dimenticata. Unendo in una stessa traiettoria tenerezza, testimonianza e denuncia, componendo una sensuale sinfonia di sapori, odori e voci, Left by the ship è una eccellente dimostrazione di un cinema italiano in grado non solo di interagire con altre realtà ma soprattutto di diventare esso stesso parte integrante delle storie che racconta, spezzando così l’isolamento che da sempre affligge il nostro cinema.
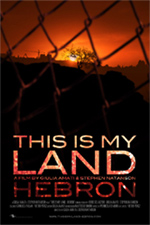 Con This is my land… Hebron Giulia Amati e Stephen Natanson si sono confrontati con la realtà del conflitto arabo-israeliano da una prospettiva inedita. Piuttosto che predicare ai già convertiti, hanno affrontato la questione drammatica dei territori occupati dai coloni osservando come questo nodo apparentemente insolubile pesi sulla coscienza israeliana (sia di destra che di sinistra). Pur concentrandosi sulla violenza subita dai palestinesi per mano dei coloni con il beneplacito dell’esercito israeliano, il film evidenzia con grande precisione come a soli trenta chilometri da Gerusalemme si affrontino due visioni dell’ebraismo e due idee diametralmente opposte di Israele. Amati e Natanson osservano come la tragedia degli abitanti palestinesi di uno dei primissimi insediamenti israeliani della West Bank, costretti a subire indicibili violenze quotidiane, si rifletta sulla coscienza degli israeliani di buona volontà. Considerata la città santa da ebrei, cristiani, musulmani, hebron è il luogo dove è sepolto Abramo. Eppure Gideon Levy, giornalista di Haaretz, non può fare a meno di notare: “non esiste un posto dell’occupazione che odio più di Hebron… è veramente il luogo del male”. Adottando uno schema narrativo che oppone frontalmente dichiarazioni provenienti da un campo e dall’altro i due registi sono riusciti di fatto a filmare la coscienza lacerata di un intero paese. Così alla dichiarazione di Noam Arnon che afferma: “la vita non è facile ad Hebron, ma quello che otteniamo vale molto di più. Diamo un senso alle nostre vite, otteniamo la consapevolezza che stiamo facendo qualcosa di importante. Ovviamente per gli ebrei, per la nostra storia e per il mondo di Dio. Ma non solo, perché stiamo facendo qualcosa di molto importante per il mondo intero”, fa da contraltare Uri Avnery che riflette: “in qualsiasi altro paese del mondo sarebbero considerati dei fascisti… se non peggio. Sono un gruppetto di circa 500 persone il cui scopo nella vita è cacciare 160.000 palestinesi… questa gente che è arrivata 30 o 40 anni fa dall’Europa considera gli abitanti di Hebron che sono lì da 5000 anni degli stranieri”. Tra i protagonisti del film figura Yehuda Shaul, ex militare israeliano, fondatore dell’associazione Breaking the S
Con This is my land… Hebron Giulia Amati e Stephen Natanson si sono confrontati con la realtà del conflitto arabo-israeliano da una prospettiva inedita. Piuttosto che predicare ai già convertiti, hanno affrontato la questione drammatica dei territori occupati dai coloni osservando come questo nodo apparentemente insolubile pesi sulla coscienza israeliana (sia di destra che di sinistra). Pur concentrandosi sulla violenza subita dai palestinesi per mano dei coloni con il beneplacito dell’esercito israeliano, il film evidenzia con grande precisione come a soli trenta chilometri da Gerusalemme si affrontino due visioni dell’ebraismo e due idee diametralmente opposte di Israele. Amati e Natanson osservano come la tragedia degli abitanti palestinesi di uno dei primissimi insediamenti israeliani della West Bank, costretti a subire indicibili violenze quotidiane, si rifletta sulla coscienza degli israeliani di buona volontà. Considerata la città santa da ebrei, cristiani, musulmani, hebron è il luogo dove è sepolto Abramo. Eppure Gideon Levy, giornalista di Haaretz, non può fare a meno di notare: “non esiste un posto dell’occupazione che odio più di Hebron… è veramente il luogo del male”. Adottando uno schema narrativo che oppone frontalmente dichiarazioni provenienti da un campo e dall’altro i due registi sono riusciti di fatto a filmare la coscienza lacerata di un intero paese. Così alla dichiarazione di Noam Arnon che afferma: “la vita non è facile ad Hebron, ma quello che otteniamo vale molto di più. Diamo un senso alle nostre vite, otteniamo la consapevolezza che stiamo facendo qualcosa di importante. Ovviamente per gli ebrei, per la nostra storia e per il mondo di Dio. Ma non solo, perché stiamo facendo qualcosa di molto importante per il mondo intero”, fa da contraltare Uri Avnery che riflette: “in qualsiasi altro paese del mondo sarebbero considerati dei fascisti… se non peggio. Sono un gruppetto di circa 500 persone il cui scopo nella vita è cacciare 160.000 palestinesi… questa gente che è arrivata 30 o 40 anni fa dall’Europa considera gli abitanti di Hebron che sono lì da 5000 anni degli stranieri”. Tra i protagonisti del film figura Yehuda Shaul, ex militare israeliano, fondatore dell’associazione Breaking the S
ilence che ricorda: “durante le prime due o tre settimane che siamo arrivati a Hebron ci siamo recati nel centro storico siamo rimasti tutti scioccati. Camminando per le strade ci siamo trovati di fronte dei graffiti che probabilmente suonano più familiari in Germania che da noi. Scritte come “arabi nelle camere a gas” o “fuori gli arabi” con la stella di Davide al centro. All’inizio un gruppo del mio plotone ha pensato di rifiutarsi di prestare servizio a Hebron. Eravamo sconvolti. Non potevamo credere a quello che vedevamo”. A fargli da contraltare nel film figura David Wilder, portavoce dei coloni che afferma: “non considero Yehuda Shaul un militare. Yehuda Shaul in qualsiasi paese normale verrebbe processato per tradimento e impiccato. Sfortunatamente Israele non ha ancora raggiunto questo livello di giustizia”.
E tutto questo senza mai dimenticare le cifre: 600 coloni, 2000 soldati israeliani in una città di 160.000 palestinesi. Attraverso i materiali forniti, tra l’altro da associazioni come B’tselem, il cui portavoce Oren Yakobovich viene interpellato nel corso del film, emerge dunque il quadro di una situazione insostenibile che non può non invocare soluzioni politiche e diplomatiche inequivocabili. Per il bene dei palestinesi e di Israele. Amati e Natanson con This is my land… Hebron sono riusciti a realizzare un film che senza puntare all’enfasi o alla complicità ideologica possiede il merito indiscutibile di offrire alla riflessione una situazione che torna a occupare le pagine dei quotidiani solo in occasione di tragedie o recrudescenze del conflitto. Attraverso uno stile sobrio e preciso nel mettere in scena una violenza devastante, Amati e Natanson offrono un contributo forte e chiaro alla causa della pace.
Premesso quindi che film come Left by the ship e This is my land… Hebron meriterebbero molto più spazio nei cinema che non tre giorni in altrettanti cinema di Roma, non possiamo che augurarci che Cinema.doc continui nel suo lavoro di promozione del documentario di creazione italiano e che la Rai valorizzi al meglio questi evitando loro la gogna del doppiaggio coatto e la notte fonda come collocazione oraria.
Il nostro cinema documentario merita decisamente di meglio.
(29 novembre 2010)
| Condividi |
MicroMega rimane a disposizione dei titolari di copyright che non fosse riuscita a raggiungere.


