Salvare la società civile araba tradita
Pierfranco Pellizzetti
«Internet ha fornito lo spazio sicuro dove
le reti dell’indignazione e della speranza
hanno potuto connettersi… Piazza Tahrir
è stata lo switcher che ha collegato tra
loro le molteplici reti del contropotere»[1]
Manuel Castells
«L’idea neoconservatrice che tutte le
società aspirino alla democrazia e
vadano inevitabilmente in quella
direzione è più forte che mai»[2]
Evgeny Morozov
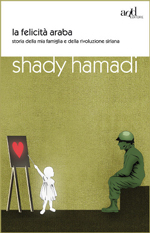 Shady Hamadi, La felicità araba, ADD, Torino 2013
Shady Hamadi, La felicità araba, ADD, Torino 2013
Nel 2006 l’editore Einaudi pubblicò un breve saggio, scritto due anni prima e intitolato “L’infelicità araba”. Nel frattempo il suo autore – Samir Kassir, giornalista libanese de Le Monde diplomatique e docente di Scienze Politiche all’Università Saint-Joseph – era stato assassinato in un attentato terroristico (il 2 giugno 2005).
La tesi di fondo di quel testo – diventato nella tragedia biografica dell’autore una sorta di lascito testamentario – era che quella “infelicità” non dipende dalla modernità, ma – semmai – dal suo mancato compimento: «la sensazione, molto diffusa e profondamente radicata, che il futuro è una strada ostruita»[3].
Oggi, a nove anni da allora, riprende il tema un ragazzo di venticinque anni – Shady Hamadi – con un libro il cui titolo sembrerebbe annunciare la tesi opposta a quella di Kassir: la condizione araba come felicità. In effetti non è assolutamente così. E l’equivoco si chiarisce subito comprendendo che i discorsi dei due autori si collocano in dimensioni temporali alternative. Potremmo dire, parafrasando Antonio Gramsci per l’ennesima volta: il primo descrive il presente con il pessimismo dell’intelligenza, l’altro prospetta un futuro auspicato facendo leva sull’ottimismo della volontà.
A chi appartiene – dunque – questa nuova voce che grida per richiamare la nostra attenzione al problema della redenzione di luoghi che si presentano come ferite sanguinanti – oggi, forse, le più profonde – nel corpo martoriato della Civiltà? Shadi Hamadi – di padre siriano e madre milanese – è l’ulteriore esempio di felice meticciato in un mondo interdipendente; al tempo stesso alla ricerca delle proprie radici. Per questo, partendo da Sesto San Giovanni, ritorna nella terra degli avi paterni e diventa attivista per i diritti umani. Per questo, con la naturale vocazione al cosmopolitismo del cresciuto in un luogo virtuale (laddove Italia e Siria si sovrappongono nell’immaginario fantastico) e la baldanza degli anni giovanili, diventa propugnatore di una rinascita araba come “Terza via”[4] tra la violenza repressiva dei regimi dittatoriali laici e l’oscurantismo dei fondamentalismi religiosi.
Chi scrive non è in grado di confermare se la Siria del passato fosse davvero quel modello di convivialità, in cui «vincolo di fratellanza e rispetto religioso è qualcosa che arriva da millenni di pacifica convivenza»[5], che ci racconta Shady; o non – piuttosto – questo sia solo uno scenario favoloso, una Fata Morgana creata dalla lontananza. E neppure è in grado di seguire l’autore sul terreno della geopolitica regionale, quando ci spiega che tutti i nodi mediorientali si scioglieranno con la sconfitta della dittatura degli Assad: «la felicità araba nascerà in Siria perché lì verranno sconfitti Hezbollah – cancro del Libano – e il regime degli Ayatollah che opprime Iran, Iraq e che è legato agli Assad»[6]. Un terremoto che potrebbe investire positivamente persino Israele, perché «il governo di Tel Aviv se fosse realmente coerente con la necessità di un processo di pace con i palestinesi prima e con gli arabi poi, come lo fu Rabin, dovrebbe favorire la caduta di Assad»[7].
Tutti argomenti su cui il dibattito storiografico e politico è aperto, cui il testo offre potenti stimoli. Ma alcuni punti del messaggio vanno immediatamente a bersaglio, anche nel caso di un lettore solo mediamente informato. In particolare due: la critica di uno stereotipo mendace quale “l’Orientalismo” (forma di eurocencentrismo fariseo criticata da Edward Said) e – insieme – la chiamata dell’Occidente alle proprie gravissime responsabilità.
Infatti la “tristezza araba” si acuisce nella grande semplificazione promossa dopo l’11 settembre dal bellicismo NeoCon; a seguito dell’opportunità, messa a disposizione dell’ordine capitalistico da parte del terrorismo jiahdista, di ricreare quell’utile antagonista “come male assoluto” che era andato smarrito nel 1989 con il crollo dell’impero sovietico. Operazione non solo militarista ma anche massmediologica, così descritta da Jean Baudrillard in polemica con i crash of civilisation cari ai propagandisti tipo Samuel Huntingthon: «non si tratta di uno scontro di civiltà né di religioni, è qualcosa che va molto al di là dell’Islam e dell’America, su cui si tenta di focalizzare il conflitto per darsi l’illusione di un confronto visibile e di una soluzione di forza… Scontro talmente inafferrabile che diviene necessario di tanto in tanto salvare l’idea della guerra con messe in scena spettacolari, come la guerra del Golfo o quella dell’Afghanistan»[8].
La finzione (contro)terroristica ha trovato definitivo smascheramento il 17 dicembre 2010 quando a Sidi Bouzid, cittadina a sud della Tunisi tunisina, l’ambulante di 26 anni Mohamed Bouaziz si diede fuoco quale estrema protesta contro le umiliazioni inflittegli dal regime dittatoriale. Allora l’incendio si propagò in tutto il mondo arabo e islamico, tra rivoluzioni dei gelsomini e dei blogger; segnalando un fenomeno in atto che conferma e rafforza le tesi del nostro amico Hamadi: la crescita di una consapevolezza collettiva (verrebbe da dire, “riflessività di massa”), irriducibile alle semplificazioni antagonistiche della lotta al terrore e su cui sarebbe possibile costruire una nuova convivenza mondializzata. Ossia non facendo riferimento all’esportabilità di modelli (leggi democrazia occidentale) che sono specifici di contesti non necessariamente riproducibili, quanto appellandosi a una universale idea di civiltà. Intesa come principio di umanità (ovvero di umana dignità).
Del resto, alla faccia di tanti pregiudizialismi su veli e presunte subordinazioni congenite, conferma e conforta il ruolo che le donne ormai hanno assunto nei grandi movimenti sociali del quadrante mediorientale. Mentre le immagini scorrono dalla cairota piazza Tharir a quella Taksim di Istambul, il 22 giugno 2013; dove si materializza l’immagine della studentessa dritta e indomita nell’affrontare il getto degli idranti manovrati dalla polizia del premier integralista islamico Tayyip Erdogan. Appunto, segno indelebile di una liberazione di genere che spazza via molti luoghi comuni, interessati a ghettizzare nello stereotipo processi di complicata gestione. E qui veniamo all’assunzione di responsabilità di noi occidentali. Partendo da quel 4 giugno 2009, quando l’amletico presidente americano Barak Obama incontra gli studenti dell’università del Cairo e pronuncia il famoso discorso del “nuovo inizio”: «io sono qui per cercare di dare un nuovo inizio tra gli Stati Uniti e i mussulmani di tutto il mondo». Detto per inciso, è indicativo il fatto che Obama identifica l’interlocutore in base alla fede (mussulmano), mentre Hamadi fa riferimento ben più laicamente alla condizione culturale e linguistica (arabo).
In ogni caso, si potrebbe dire che il dramma degli anni successivi è derivato dal fatto che quegli studenti e quelle studentesse presero in parola il “comandante in ca
po” della massima potenza militare occidentale; che – al momento delle scelte – ha preferito ripiegare nelle solite soluzioni scriteriate e miopissime di appoggiare la riappropriazione delle piazze da parte dei collaudati gendarmi al servizio dell’ottuso ordine vigente. Seppure funzionale ai presunti interessi a breve dell’Occidente.
Tanto che – scrive Hamadi a proposito dei suoi coetanei mediorientali – «i giovani sono diventati consapevoli di essere soli». Sicché, leggendo il suo libro, si può riflettere sulla disastrosa pazzia di aver abbandonato a se stessa l’unica promessa di un’evoluzione civile che si oppone con ammirevole coraggio alle orride “prime due vie” del passato: i regimi dittatoriali e quelli teocratici. Ordini basati sulla paura, appoggiati “per paura” da democrazie che invecchiando perdono la capacità di investire generosamente sul futuro. E quindi imbarbariscono.
Eppure – con le parole di un altro intellettuale a cavallo tra più mondi, Tzvetan Todorov – «il gioco non vale più la candela. Se per sconfiggere il nemico si imitano i suoi atti più sordidi, è ancora la barbarie a vincere»[9].
NOTE
[1] M. Castells, Reti di indignazione e speranza, EGEA, Milano 2012 pag. 58
[2] E. Morozov, L’ingenuità della rete, Codice, Torino 2011 pag. 36
[3] S. Kassir, L’infelicità araba, Einaudi, Torino 2006 pag. 3
[4] S. Hamadi, op. cit. pag. 23
[5] ibidem pag. 243
[6] ibidem pag. 130
[7] ibidem pag. 133
[8] J. Baudrillard, Lo spirito del terrorismo, Cortina, Roma 2002 pag. 16
[9] T. Todorov, La paura dei barbari, Garzanti, Milano 2009 pag. 154
(4 novembre 2013)
MicroMega rimane a disposizione dei titolari di copyright che non fosse riuscita a raggiungere.

